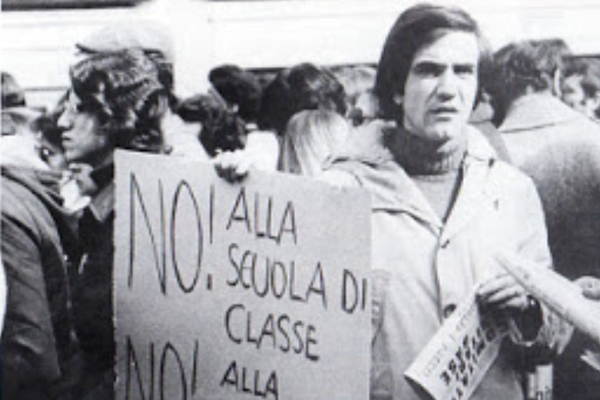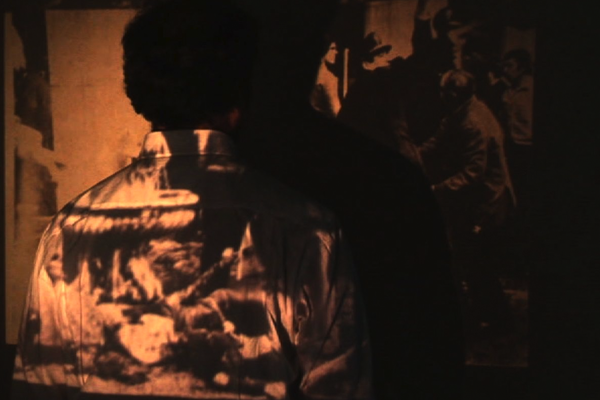ACF
| ID | 249941 |
| key | field_606c8a07f214f |
| label | Biografia |
| name | biografia |
| prefix | acf |
| type | wysiwyg |
| value | <figure id="imgLeft"><img decoding="async" src="https://www.memoriaritrovata.it/wp-content/uploads/2021/06/pinto-topaz-enhance-4x-faceai.jpeg" alt="" width="300px" /></figure> <p>Luigi Pinto, foggiano, è una delle 8 vittime della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974.<br /> Nato a Foggia l’8 maggio 1949, Luigi Pinto era un militante della Cgil Scuola e di Avanguardia Operaia. Fin dai banchi di scuola – è stato uno studente dell’ITIS Altamura, dove si è diplomato – ha manifestato una spiccata passione per la scuola che sognava democratica, aperta a tutti, fattore propulsivo di giustizia sociale.<br /> La sua gioventù non è stata facile. Quando aveva solo 13 anni è venuta a mancare sua madre.<br /> Si è adattato a diversi mestieri: proiezionista al cineteatro Ariston di Foggia, riparatore di lavatrici, quindi operaio in uno zuccherificio e minatore in Sardegna. Si iscrive a due concorsi: nelle Ferrovie dello Stato e nella scuola. Li supererà entrambi ma alla fine Luigi sceglierà la strada che ha sempre sognato: nella scuola, per cercare di cambiarla, dal di dentro. Diventa insegnante di Applicazioni tecniche nella scuola media, con diversi incarichi che lo porteranno a Rovigo, poi in provincia di Mantova, e infine a Siviano di Montisola, in provincia di Brescia.<br /> Nel settembre del 1973, Luigi Pinto sposò Ada Bardini, una compagna della scuola. Nello stesso anno ottenne la tanto attesa nomina a tempo indeterminato.<br /> Il 28 maggio 1974, giorno della strade, Luigi Pinto era in piazza della Loggia a Brescia assieme ad altre migliaia di persone per manifestare contro le continue provocazioni e gli attentati dei neofascisti a Brescia e nella provincia. L’1 giugno avrebbe dovuto partecipare al congresso provinciale della Cgil Scuola, invece sarà la data della sua morte, dopo un’agonia atroce durata diversi giorni. Aveva solo 25 anni.<br /> I suoi funerali, svoltisi a Foggia il 4 giugno del 1874 hanno rappresentato una delle manifestazioni popolari più partecipate che la storia civile della città ricordi. La città gli ha dedicato un importante viale. La Flc Cgil gli ha fatto erigere un monumento, disegnato dall’architetto Michele Sisbarra, mentre il regista foggiano Lucio Dell’Accio ha realizzato su Luigi Pinto e sulla strage di Brescia l’apprezzato documentario Scene di una Strage.<br /> Foggia ricorda Luigi Pinto ogni anno, con una serie di iniziative promosse in occasione dell’anniversario della strage con lo scopo di mantenere viva la memoria di quei tragici eventi e di contrastare ogni tentativo di revisionismo o offuscamento delle verità storiche.</p> |
| menu_order | 1 |
| instructions | La immagine di anteprima deve essere quadrata di dimensioni di 600px x 600px. Sostituire nella scheda "Testo", la stringa "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" con l'indicazione dello stesso percorso della Featured Image. Dopo di che, aggiungere il testo della biografia del personaggio. Se il testo della biografia è troppo lungo, inserire il tag nel punto in cui si vuole interrompere la lettura: [expander_maker id="2" more="Continua a leggere..." less="Leggi di meno..."] e chiudere alla fine del testo con il tag: [/expander_maker] |
| required | 1 |
| parent | 249933 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| default_value | <figure id="imgLeft"><img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" width="300px" alt=""></figure> |
| tabs | all |
| toolbar | full |
| media_upload | 1 |
| _name | biografia |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_606c8a07f214f |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| _builder_version | 4.20.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | justify |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 18px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1.3em |
| acf_label_css_font | |700|on|||||| |
| acf_label_css_font_size | 18px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 14px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| title_css_font_size_tablet | 18px |
| title_css_font_size_phone | 14px |
| title_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |

Luigi Pinto, foggiano, è una delle 8 vittime della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974.
Nato a Foggia l’8 maggio 1949, Luigi Pinto era un militante della Cgil Scuola e di Avanguardia Operaia. Fin dai banchi di scuola – è stato uno studente dell’ITIS Altamura, dove si è diplomato – ha manifestato una spiccata passione per la scuola che sognava democratica, aperta a tutti, fattore propulsivo di giustizia sociale.
La sua gioventù non è stata facile. Quando aveva solo 13 anni è venuta a mancare sua madre.
Si è adattato a diversi mestieri: proiezionista al cineteatro Ariston di Foggia, riparatore di lavatrici, quindi operaio in uno zuccherificio e minatore in Sardegna. Si iscrive a due concorsi: nelle Ferrovie dello Stato e nella scuola. Li supererà entrambi ma alla fine Luigi sceglierà la strada che ha sempre sognato: nella scuola, per cercare di cambiarla, dal di dentro. Diventa insegnante di Applicazioni tecniche nella scuola media, con diversi incarichi che lo porteranno a Rovigo, poi in provincia di Mantova, e infine a Siviano di Montisola, in provincia di Brescia.
Nel settembre del 1973, Luigi Pinto sposò Ada Bardini, una compagna della scuola. Nello stesso anno ottenne la tanto attesa nomina a tempo indeterminato.
Il 28 maggio 1974, giorno della strade, Luigi Pinto era in piazza della Loggia a Brescia assieme ad altre migliaia di persone per manifestare contro le continue provocazioni e gli attentati dei neofascisti a Brescia e nella provincia. L’1 giugno avrebbe dovuto partecipare al congresso provinciale della Cgil Scuola, invece sarà la data della sua morte, dopo un’agonia atroce durata diversi giorni. Aveva solo 25 anni.
I suoi funerali, svoltisi a Foggia il 4 giugno del 1874 hanno rappresentato una delle manifestazioni popolari più partecipate che la storia civile della città ricordi. La città gli ha dedicato un importante viale. La Flc Cgil gli ha fatto erigere un monumento, disegnato dall’architetto Michele Sisbarra, mentre il regista foggiano Lucio Dell’Accio ha realizzato su Luigi Pinto e sulla strage di Brescia l’apprezzato documentario Scene di una Strage.
Foggia ricorda Luigi Pinto ogni anno, con una serie di iniziative promosse in occasione dell’anniversario della strage con lo scopo di mantenere viva la memoria di quei tragici eventi e di contrastare ogni tentativo di revisionismo o offuscamento delle verità storiche.
Execution time: 0.0028 seconds
Args
| post_type |
| ||||
| post_status | publish | ||||
| posts_per_page | 16 | ||||
| meta_query |
| ||||
| tax_query |
| ||||
| post__not_in |
| ||||
| orderby |
| ||||
| meta_key | data_ordinamento | ||||
| relevanssi | true |
Module Settings
| post_type_choose | memorie|off|off|off|off|off|off|off|off|on |
| loop_style | custom_loop_layout |
| shortcode_name | [de_loop_template_shortcode] |
| loop_templates | divi-blog |
| custom_loop_template | none |
| loop_layout | 281973 |
| filter_update_animation | load-3 |
| animation_color | #E02B20 |
| loading_bg_color | #D6D6D6 |
| no_posts_layout | 1369 |
| no_posts_layout_text | Sorry, No posts. |
| is_main_loop | on |
| include_current_terms | off |
| groupping_post_object | off |
| groupping_taxonomy | none |
| show_empty_onload | off |
| post_status | publish |
| show_current_post | off |
| posts_number | 16 |
| post_offset | 0 |
| post_display_type | linked_post |
| saved_type | wishlist |
| acf_linked_acf | field_608106706e5d9 |
| related_content | categories |
| related_acf_field | none |
| related_content_categories | default |
| is_category_loop | off |
| disable_sticky_posts | off |
| specific_post_objects | off |
| related_content_tags | default |
| tax_name_related | none |
| acf_name_related | none |
| custom_tax_choose | dflip_category |
| acf_name | none |
| include_sticky_posts | on |
| include_sticky_posts_only | off |
| onload_tax_choose | post |
| sort_order | acf_date_picker |
| acf_sort_field | none |
| acf_sort_type | string |
| acf_date_picker_field | field_6090267cc15e4 |
| acf_date_picker_method | default |
| acf_date_picker_custom_day | 30 |
| order_asc_desc | ASC |
| sec_acf_sort_field | none |
| sec_acf_sort_type | string |
| sec_acf_date_picker_field | none |
| sec_order_asc_desc | ASC |
| enable_loadmore | pagination |
| pagination_position | bottom |
| scrollto | on |
| scrollto_fine_tune | 0px |
| loadmore_text | Load More |
| loadmore_text_loading | Loading... |
| enable_resultcount | on |
| resultcount_position | left |
| result_count_single_text | Visualizzata una sola Memoria |
| result_count_all_text | Visualizzate tutte %d Memorie |
| result_count_pagination_text | Visualizzate %d-%d di %d Memorie |
| has_map | off |
| map_all_posts | off |
| map_all_posts_limit | -1 |
| map_infoview_layout | none |
| map_infoview_layout_ajax | off |
| hide_marker_label | off |
| map_cluster | on |
| map_center_first_post | on |
| link_whole_gird | off |
| link_whole_gird_external | off |
| external_acf | none |
| content_section_layout | none |
| grid_layout | grid |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| custom_gutter_width | off |
| grid_list_default | list |
| grid_list_position | left |
| grid_list_cookie_time | 30 |
| grid_view_icon | ||divi||400 |
| list_view_icon | ||fa||900 |
| icon_padding | 7px|7px|7px|7px |
| icon_margin | 0px|10px|0px|0px |
| enable_overlay | on |
| show_featured_image | on |
| show_read_more | off |
| read_more_text | Read More |
| show_author | on |
| show_date | on |
| date_format | F j, Y |
| show_categories | on |
| show_content | off |
| excerpt_length | 270 |
| excerpt_more | ... |
| show_comments | off |
| meta_separator | | |
| content_visibility | hover |
| image_hover_animation | none |
| loop_template_content_alignment | center_center |
| loop_template_color_theme | light |
| loop_template_same_height | on |
| image_min_height | 150px |
| image_max_height | 500px |
| pagination_item_background | #fff |
| pagination_item_background_active | #ebe9eb |
| _builder_version | 4.21.0 |
| _module_preset | default |
| grouping_tax_title_font_size | 14px |
| grouping_tax_title_letter_spacing | 0px |
| grouping_tax_title_line_height | 1em |
| title_font_size | 14px |
| title_letter_spacing | 0px |
| title_line_height | 1em |
| excerpt_font_size | 14px |
| excerpt_letter_spacing | 0px |
| excerpt_line_height | 1em |
| loop_template_meta_font_size | 14px |
| loop_template_meta_letter_spacing | 0px |
| loop_template_meta_line_height | 1em |
| loop_template_meta_a_font_size | 14px |
| loop_template_meta_a_letter_spacing | 0px |
| loop_template_meta_a_line_height | 1em |
| loop_template_a_font_size | 14px |
| loop_template_a_letter_spacing | 0px |
| loop_template_a_line_height | 1em |
| pagination_font_letter_spacing | 0px |
| active_pagination_letter_spacing | 0px |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| custom_loop_template_button | off |
| loop_template_button_text_size | 18 |
| loop_template_button_bg_use_color_gradient | off |
| loop_template_button_bg_color_gradient_repeat | off |
| loop_template_button_bg_color_gradient_type | linear |
| loop_template_button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| loop_template_button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| loop_template_button_bg_color_gradient_unit | % |
| loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| loop_template_button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| loop_template_button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| loop_template_button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| loop_template_button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| loop_template_button_bg_enable_image | on |
| loop_template_button_bg_parallax | off |
| loop_template_button_bg_parallax_method | on |
| loop_template_button_bg_size | cover |
| loop_template_button_bg_image_width | auto |
| loop_template_button_bg_image_height | auto |
| loop_template_button_bg_position | center |
| loop_template_button_bg_horizontal_offset | 0 |
| loop_template_button_bg_vertical_offset | 0 |
| loop_template_button_bg_repeat | no-repeat |
| loop_template_button_bg_blend | normal |
| loop_template_button_bg_enable_video_mp4 | on |
| loop_template_button_bg_enable_video_webm | on |
| loop_template_button_bg_allow_player_pause | off |
| loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| loop_template_button_use_icon | on |
| loop_template_button_icon_placement | right |
| loop_template_button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| grouping_tax_title_text_shadow_style | none |
| grouping_tax_title_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| grouping_tax_title_text_shadow_vertical_length | 0em |
| grouping_tax_title_text_shadow_blur_strength | 0em |
| grouping_tax_title_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| title_text_shadow_style | none |
| title_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| excerpt_text_shadow_style | none |
| excerpt_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| excerpt_text_shadow_vertical_length | 0em |
| excerpt_text_shadow_blur_strength | 0em |
| excerpt_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| loop_template_meta_text_shadow_style | none |
| loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| loop_template_meta_text_shadow_vertical_length | 0em |
| loop_template_meta_text_shadow_blur_strength | 0em |
| loop_template_meta_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| loop_template_meta_a_text_shadow_style | none |
| loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length | 0em |
| loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength | 0em |
| loop_template_meta_a_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| loop_template_a_text_shadow_style | none |
| loop_template_a_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| loop_template_a_text_shadow_vertical_length | 0em |
| loop_template_a_text_shadow_blur_strength | 0em |
| loop_template_a_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| pagination_font_text_shadow_style | none |
| pagination_font_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| pagination_font_text_shadow_vertical_length | 0em |
| pagination_font_text_shadow_blur_strength | 0em |
| pagination_font_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| active_pagination_text_shadow_style | none |
| active_pagination_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| active_pagination_text_shadow_vertical_length | 0em |
| active_pagination_text_shadow_blur_strength | 0em |
| active_pagination_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| loop_template_button_text_shadow_style | none |
| loop_template_button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| loop_template_button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| loop_template_button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| loop_template_button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_product | none |
| box_shadow_color_product | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_product | outer |
| box_shadow_style_grid_list_view_button | none |
| box_shadow_color_grid_list_view_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_grid_list_view_button | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| box_shadow_style_loop_template_button | none |
| box_shadow_color_loop_template_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_loop_template_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ritaglio di stampa |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
ritaglio di stampa
Execution time: 0.0014 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 01/06/1974 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
01/06/1974
Execution time: 0.0016 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
Execution time: 0.0003 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Lettere Meridiane |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Lettere Meridiane
Execution time: 0.0014 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ritaglio di stampa |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
ritaglio di stampa
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 04/06/1974 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
04/06/1974
Execution time: 0.0019 seconds
Execution time: 0.0005 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Michele Casalucci |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Michele Casalucci
Execution time: 0.0023 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | pellicola |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
pellicola
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 04/06/1974 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
04/06/1974
Execution time: 0.0017 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Cgil |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Cgil
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | pellicola |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
pellicola
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 04/06/1974 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
04/06/1974
Execution time: 0.0017 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Matteo Carella |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Matteo Carella
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ritaglio di stampa |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
ritaglio di stampa
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 01/06/2014 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
01/06/2014
Execution time: 0.0017 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Lettere Meridiane |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Lettere Meridiane
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ritaglio di stampa |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
ritaglio di stampa
Execution time: 0.0025 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 03/06/2015 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
03/06/2015
Execution time: 0.0020 seconds
Execution time: 0.0007 seconds
Execution time: 0.0006 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Lettere Meridiane |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Lettere Meridiane
Execution time: 0.0023 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Sconosciuta |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Sconosciuta
Execution time: 0.0022 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ritaglio di stampa |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
ritaglio di stampa
Execution time: 0.0017 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 28/05/2020 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
28/05/2020
Execution time: 0.0017 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Lettere Meridiane |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Lettere Meridiane
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | oggetto digitale (galleria) |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
oggetto digitale (galleria)
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 03/06/2021 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
03/06/2021
Execution time: 0.0018 seconds
Execution time: 0.0005 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ANPI |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
ANPI
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | ritaglio di stampa |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
ritaglio di stampa
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 06/06/2021 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
06/06/2021
Execution time: 0.0021 seconds
Execution time: 0.0006 seconds
Execution time: 0.0006 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Geppe Inserra |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Geppe Inserra
Execution time: 0.0022 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0023 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | oggetto digitale (pdf) |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
oggetto digitale (pdf)
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 08/06/2021 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
08/06/2021
Execution time: 0.0021 seconds
Execution time: 0.0005 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Lucio Dell'Accio |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Lucio Dell'Accio
Execution time: 0.0017 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | oggetto digitale (galleria) |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
oggetto digitale (galleria)
Execution time: 0.0017 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 01/06/2022 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
01/06/2022
Execution time: 0.0017 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Geppe Inserra |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Geppe Inserra
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0015 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | video |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
video
Execution time: 0.0017 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 27/05/2024 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
27/05/2024
Execution time: 0.0018 seconds
Execution time: 0.0005 seconds
Execution time: 0.0006 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Archivio della Memoria Ritrovata |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Archivio della Memoria Ritrovata
Execution time: 0.0019 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0021 seconds
ACF
| ID | 248768 |
| key | field_6065e06905487 |
| label | Natura analogica |
| name | natura_analogica |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | video |
| menu_order | 1 |
| instructions | Spuntare il pulsante relativo al tipo di natura dell'oggetto. Se l'oggetto è di tipo diverso, cliccare sul pulsante vuoto e compilare il campo inserendovi testo libero. |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| choices | Array ( [oggetto digitale (pdf)] => Oggetto digitale (Pdf) [testo a stampa] => Testo a stampa [documento testo] => Documento di Testo [manoscritto] => Manoscritto [ritaglio di stampa] => Ritaglio di stampa [audio non musicale] => Audio non musicale [audio musicale] => Audio musicale [album fotografico] => Album fotografico [oggetto digitale (galleria)] => Oggetto digitale (galleria) [raccolta di diapositive] => Raccolta di diapositive [fotografia] => Fotografia [oggetto digitale (foto)] => Oggetto digitale (foto) [diapositiva] => Diapositiva [materiale grafico] => Materiale grafico [pellicola] => Pellicola [video] => Video ) |
| allow_null | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| show_column_weight | 1000 |
| allow_quickedit | 1 |
| allow_bulkedit | 1 |
| _name | natura_analogica |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | ACF Item |
| acf_name | field_6065e06905487 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_pos_left | 5px |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 3 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | field_6065e069051ec |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | tipo di oggetto |
| _builder_version | 4.23.1 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| title_css_font_size | 14px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600|on|||||| |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_text_color | RGBA(255,255,255,0) |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_color | RGBA(255,255,255,0) |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | 95% |
| max_width | 95% |
| module_alignment | center |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||20px|false|false |
| custom_margin_tablet | ||||false|false |
| custom_margin_phone | |||20px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||6px||false|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 11px |
| label_css_font_size_phone | 9px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| locked | off |
| global_colors_info | {} |
video
Execution time: 0.0021 seconds
ACF
| ID | 248772 |
| key | field_6065e06905555 |
| label | Data |
| name | data |
| prefix | acf |
| type | date_picker |
| value | 01/06/2024 |
| menu_order | 23 |
| instructions | Compilare questo campo solo se si conosce la data esatta dell'oggetto. Diversamente compilare "Anno" o "Data di massima". Nel caso di creazione di una memoria "BIOGRAFIA" di una persona, la data da inserire è la data di nascita della persona in oggetto. |
| conditional_logic | Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [field] => field_6065e0690551e [operator] => == [value] => Data esatta ) ) ) |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| display_format | d/m/Y |
| return_format | d/m/Y |
| first_day | 1 |
| show_column_weight | 1000 |
| _name | data |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | data |
| acf_name | field_6065e06905555 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | left |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | data1 |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #E02B20 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 14px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | |||6px|false|false |
| custom_margin_tablet | |||6px|false|false |
| custom_margin_phone | |||6px|false|false |
| custom_margin_last_edited | on|phone |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
01/06/2024
Execution time: 0.0019 seconds
Execution time: 0.0005 seconds
Execution time: 0.0004 seconds
ACF
| ID | 248770 |
| key | field_6065e069054e6 |
| label | Contributore |
| name | contributore |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Archivio della Memoria Ritrovata |
| menu_order | 27 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuto] => Sconosciuto [ANPI] => ANPI [Antonio Manganiello] => Antonio Manganiello [Auser] => Auser [auser] => auser [Cgil] => Cgil [Fondazione della Camera dei Deputati] => Fondazione cella Camera dei Deputati [Fondazione Foa] => Fondazione Foa [Fondazione Gramsci Puglia] => Fondazione Gramsci Puglia [Lega di ...] => Lega di ... [Lettere Meridiane] => Lettere Meridiane [L'Unita'] => L'Unita' [Matteo Carella] => Matteo Carella [Michele Galante] => Michele Galante [Michele Magno] => Michele Magno [Severino Cannelonga] => Severino Cannelonga [Spi Cgil] => Spi Cgil [Sudest] => Sudest [Michele Di Stefano] => Michele Di Stefano [Franco Acquaviva] => Franco Acquaviva [Geppe Inserra] => Geppe Inserra [Lucio Dell'Accio] => Lucio Dell'Accio [Michele Casalucci] => Michele Casalucci [Archivio della Memoria Ritrovata] => Archivio della Memoria Ritrovata [Peperoncino Rosso] => Peperoncino Rosso [Rinascita] => Rinascita [Istituto Luce] => Istituto Luce [Carlo Inserra] => Carlo Inserra [Tonio Sereno] => Tonio Sereno [Gino Annolfi] => Gino Annolfi [Maurizio Carmeno] => Maurizio Carmeno [Fabio Castrignano] => Fabio Castrignano [Lello Saracino] => Lello Saracino [Leo Di Castro] => Leo Di Castro [Carmine Muggeo] => Carmine Muggeo [Auser di Castelnuovo della Daunia] => Auser di Castelnuovo della Daunia [Donato Renzulli] => Donato Renzulli [Auser San Severo] => Auser San Severo [Sabatino Aldo] => Sabatino Aldo ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | contributore |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | contributore |
| acf_name | field_6065e069054e6 |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | center |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | contributore |
| _builder_version | 4.24.0 |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 10px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_align | left |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 10px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Archivio della Memoria Ritrovata
Execution time: 0.0016 seconds
ACF
| ID | 248775 |
| key | field_6065e069055fb |
| label | Localizzazione |
| name | localizzazione |
| prefix | acf |
| type | radio |
| value | Foggia |
| menu_order | 21 |
| instructions | Se non si conosce l'esatta località, indicare la zona (ad es. Gargano, Monti Dauni, Capitanata, Puglia...) |
| required | 1 |
| parent | 248747 |
| wrapper | Array ( [width] => [class] => [id] => ) |
| show_column_weight | 1000 |
| choices | Array ( [Sconosciuta] => Sconosciuta [Ascoli Satriano] => Ascoli Satriano [Cerignola] => Cerignola [Foggia] => Foggia [Gargano] => Gargano [Italia] => Italia [Lucera] => Lucera [Manfredonia] => Manfredonia [Monteleone di Puglia] => Monteleone di Puglia [Monti Dauni] => Monti Dauni [Provincia di Foggia] => Provincia di Foggia [Puglia] => Puglia [Riccione] => Riccione [Roma] => Roma [San Giovanni Rotondo] => San Giovanni Rotondo [San Nicandro Garganico] => San Nicandro Garganico [San Paolo di Civitate] => San Paolo di Civitate [San Severo] => San Severo [Torremaggiore] => Torremaggiore [Candela] => Candela [Ischitella] => Ischitella [San Paolo Civitate] => San Paolo Civitate [Bari] => Bari [Orta Nova] => Orta Nova [Bovino] => Bovino [Trinitapoli] => Trinitapoli [Napoli] => Napoli [Milano] => Milano [Castelluccio dei Sauri] => Castelluccio dei Sauri [Castelnuovo della Daunia] => Castelnuovo della Daunia ) |
| other_choice | 1 |
| save_other_choice | 1 |
| layout | horizontal |
| return_format | value |
| _name | localizzazione |
| _valid | 1 |
Module Settings
| custom_identifier | luogo |
| acf_name | field_6065e069055fb |
| is_author_acf_field | off |
| post_object_acf_name | none |
| author_field_type | author_post |
| linked_user_acf_name | none |
| type_taxonomy_acf_name | none |
| acf_tag | p |
| show_label | off |
| label_seperator | : |
| visibility | on |
| empty_value_option | hide_module |
| element_in_section | off |
| use_icon | off |
| icon_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle | off |
| circle_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_circle_border | off |
| circle_border_color | rgba(226,98,43,0.22) |
| use_icon_font_size | off |
| icon_image_placement | left |
| image_mobile_stacking | initial |
| return_format | array |
| auto_detect_video_audio | on |
| image_link_url | off |
| image_link_url_acf_name | none |
| checkbox_style | array |
| checkbox_radio_return | label |
| checkbox_radio_value_type | off |
| checkbox_radio_link | off |
| link_button | off |
| email_subject | none |
| email_body_after | none |
| add_css_class | off |
| add_css_loop_layout | off |
| add_css_class_selector | body |
| link_new_tab | on |
| link_name_acf | off |
| link_name_acf_name | none |
| url_link_icon | off |
| url_as_image | off |
| image_size | full |
| image_full_width | off |
| true_false_condition | off |
| true_false_condition_css_selector | .et_pb_button |
| true_false_text_true | True |
| true_false_text_false | False |
| is_audio | off |
| is_video | off |
| video_keep_aspect_ratio | on |
| video_loop | on |
| video_autoplay | on |
| make_video_background | off |
| video_background_size | cover |
| is_oembed_video | off |
| defer_video | off |
| defer_video_icon | I||divi||400 |
| video_icon_font_size | off |
| pretify_text | off |
| pretify_seperator | , |
| number_decimal | . |
| show_value_if_zero | off |
| text_image | off |
| is_options_page | off |
| is_repeater_loop_layout | off |
| linked_post_style | custom |
| link_post_seperator | , |
| link_to_post_object | on |
| link_to_post_object_new_tab | off |
| loop_layout | none |
| columns | 4 |
| columns_tablet | 2 |
| columns_mobile | 1 |
| user_field_return | display_name |
| link_to_author_page | off |
| repeater_dyn_btn_acf | none |
| button_alignment | right |
| text_before_position | same_line |
| label_position | same_line |
| vertical_alignment | middle |
| admin_label | luogo |
| _builder_version | 4.24.0 |
| _module_preset | default |
| title_css_text_align | left |
| title_css_text_color | #000000 |
| title_css_font_size | 9px |
| title_css_letter_spacing | 0px |
| title_css_line_height | 1em |
| acf_label_css_text_color | #000000 |
| acf_label_css_font_size | 9px |
| acf_label_css_letter_spacing | 0px |
| acf_label_css_line_height | 1em |
| label_css_font | |600||||||| |
| label_css_text_align | left |
| label_css_text_color | #000000 |
| label_css_font_size | 11px |
| label_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_font_size | 14px |
| text_before_css_letter_spacing | 0px |
| text_before_css_line_height | 1em |
| seperator_font_size | 14px |
| seperator_letter_spacing | 0px |
| seperator_line_height | 1em |
| relational_field_item_font_size | 14px |
| relational_field_item_letter_spacing | 0px |
| relational_field_item_line_height | 1em |
| background_enable_color | on |
| use_background_color_gradient | off |
| background_color_gradient_repeat | off |
| background_color_gradient_type | linear |
| background_color_gradient_direction | 180deg |
| background_color_gradient_direction_radial | center |
| background_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| background_color_gradient_unit | % |
| background_color_gradient_overlays_image | off |
| background_color_gradient_start | #2b87da |
| background_color_gradient_start_position | 0% |
| background_color_gradient_end | #29c4a9 |
| background_color_gradient_end_position | 100% |
| background_enable_image | on |
| parallax | off |
| parallax_method | on |
| background_size | cover |
| background_image_width | auto |
| background_image_height | auto |
| background_position | center |
| background_horizontal_offset | 0 |
| background_vertical_offset | 0 |
| background_repeat | no-repeat |
| background_blend | normal |
| background_enable_video_mp4 | on |
| background_enable_video_webm | on |
| allow_player_pause | off |
| background_video_pause_outside_viewport | on |
| background_enable_pattern_style | off |
| background_pattern_style | polka-dots |
| background_pattern_color | rgba(0,0,0,0.2) |
| background_pattern_size | initial |
| background_pattern_width | auto |
| background_pattern_height | auto |
| background_pattern_repeat_origin | top_left |
| background_pattern_horizontal_offset | 0 |
| background_pattern_vertical_offset | 0 |
| background_pattern_repeat | repeat |
| background_pattern_blend_mode | normal |
| background_enable_mask_style | off |
| background_mask_style | layer-blob |
| background_mask_color | #ffffff |
| background_mask_aspect_ratio | landscape |
| background_mask_size | stretch |
| background_mask_width | auto |
| background_mask_height | auto |
| background_mask_position | center |
| background_mask_horizontal_offset | 0 |
| background_mask_vertical_offset | 0 |
| background_mask_blend_mode | normal |
| custom_button | off |
| button_text_size | 18 |
| button_bg_use_color_gradient | off |
| button_bg_color_gradient_repeat | off |
| button_bg_color_gradient_type | linear |
| button_bg_color_gradient_direction | 180deg |
| button_bg_color_gradient_direction_radial | center |
| button_bg_color_gradient_stops | #2b87da 0%|#29c4a9 100% |
| button_bg_color_gradient_unit | % |
| button_bg_color_gradient_overlays_image | off |
| button_bg_color_gradient_start | #2b87da |
| button_bg_color_gradient_start_position | 0% |
| button_bg_color_gradient_end | #29c4a9 |
| button_bg_color_gradient_end_position | 100% |
| button_bg_enable_image | on |
| button_bg_parallax | off |
| button_bg_parallax_method | on |
| button_bg_size | cover |
| button_bg_image_width | auto |
| button_bg_image_height | auto |
| button_bg_position | center |
| button_bg_horizontal_offset | 0 |
| button_bg_vertical_offset | 0 |
| button_bg_repeat | no-repeat |
| button_bg_blend | normal |
| button_bg_enable_video_mp4 | on |
| button_bg_enable_video_webm | on |
| button_bg_allow_player_pause | off |
| button_bg_video_pause_outside_viewport | on |
| button_use_icon | on |
| button_icon_placement | right |
| button_on_hover | on |
| positioning | none |
| position_origin_a | top_left |
| position_origin_f | top_left |
| position_origin_r | top_left |
| text_orientation | left |
| width | auto |
| max_width | none |
| module_alignment | left |
| min_height | auto |
| height | auto |
| max_height | none |
| custom_margin | ||||false|true |
| custom_padding | ||||true|false |
| filter_hue_rotate | 0deg |
| filter_saturate | 100% |
| filter_brightness | 100% |
| filter_contrast | 100% |
| filter_invert | 0% |
| filter_sepia | 0% |
| filter_opacity | 100% |
| filter_blur | 0px |
| mix_blend_mode | normal |
| animation_style | none |
| animation_direction | center |
| animation_duration | 1000ms |
| animation_delay | 0ms |
| animation_intensity_slide | 50% |
| animation_intensity_zoom | 50% |
| animation_intensity_flip | 50% |
| animation_intensity_fold | 50% |
| animation_intensity_roll | 50% |
| animation_starting_opacity | 0% |
| animation_speed_curve | ease-in-out |
| animation_repeat | once |
| hover_transition_duration | 300ms |
| hover_transition_delay | 0ms |
| hover_transition_speed_curve | ease |
| link_option_url_new_window | off |
| sticky_position | none |
| sticky_offset_top | 0px |
| sticky_offset_bottom | 0px |
| sticky_limit_top | none |
| sticky_limit_bottom | none |
| sticky_offset_surrounding | on |
| sticky_transition | on |
| motion_trigger_start | middle |
| hover_enabled | 0 |
| label_css_font_size_tablet | 10px |
| label_css_font_size_phone | 10px |
| label_css_font_size_last_edited | on|phone |
| title_css_text_shadow_style | none |
| title_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| title_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| title_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| title_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| acf_label_css_text_shadow_style | none |
| acf_label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| acf_label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| label_css_text_shadow_style | none |
| label_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| label_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| label_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| label_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| text_before_css_text_shadow_style | none |
| text_before_css_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_before_css_text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_before_css_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| seperator_text_shadow_style | none |
| seperator_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| seperator_text_shadow_vertical_length | 0em |
| seperator_text_shadow_blur_strength | 0em |
| seperator_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| relational_field_item_text_shadow_style | none |
| relational_field_item_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_vertical_length | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_blur_strength | 0em |
| relational_field_item_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| button_text_shadow_style | none |
| button_text_shadow_horizontal_length | 0em |
| button_text_shadow_vertical_length | 0em |
| button_text_shadow_blur_strength | 0em |
| button_text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| box_shadow_style | none |
| box_shadow_color | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position | outer |
| box_shadow_style_button | none |
| box_shadow_color_button | rgba(0,0,0,0.3) |
| box_shadow_position_button | outer |
| text_shadow_style | none |
| text_shadow_horizontal_length | 0em |
| text_shadow_vertical_length | 0em |
| text_shadow_blur_strength | 0em |
| text_shadow_color | rgba(0,0,0,0.4) |
| disabled | off |
| global_colors_info | {} |
Foggia
Execution time: 0.0016 seconds
Visualizzate tutte 13 Memorie